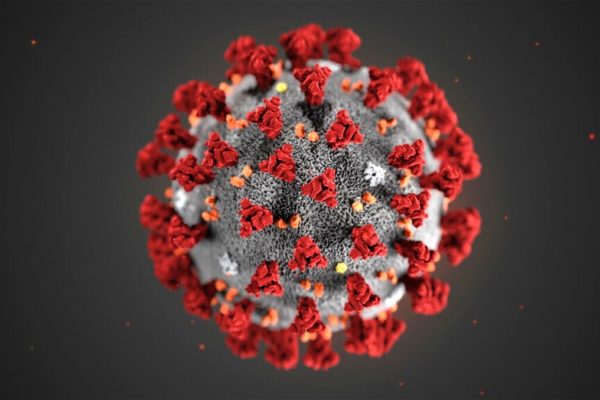La campagna #odiareticosta nasce da un’associazione, che è anche una casa editrice dallo splendido nome borghesiano, Tlon, e da uno studio legale. Forse ne avrete sentito parlare. Il principio è semplice: se uno commette un reato nello spazio digitale, e quel reato non è perseguibile (o perseguito) d’ufficio ma su querela di parte, l’associazione lo farà. Immaginiamo che i reati saranno quelli di diffamazione, di stalking, in alcuni casi, più in generale quelli legati al cosiddetto hate speech.
Una presa di posizione simile ha due obiettivi.
Potremmo definire il primo educativo: non si può dire quello che si vuole in rete, così come non si può dire quello che si vuole per strada. Se un tizio mi insulta per strada, lo denuncio.
Il secondo obiettivo è un effetto diretto del primo: e cioè la speranza – ché di speranza si tratta – che la sola evocazione dei soldi, sotto forma di risarcimento del danno, porti a un clima migliore nei social network. Un effetto di dissuasione intelligente, a basso costo direi.
Dopotutto chi è impegnato con serietà su questo fronte lo fa con l’educazione (pensiamo al lavoro meritorio di Parole O_Stili), oppure con la repressione, la Polizia, nel caso di #odiareticosta lo si fa adottando le tutele previste dalla legge, come singoli, come cittadini. Oggi qualcuno critica questo modo di procedere e lo fa sulla base di assunti sbagliati e provocatori. Quelli provocatori nutrono il dibattito sul tema, quelli sbagliati sono semplicemente sbagliati.
Il primo errore è, per esempio, affermare che si sanzionano le azioni e non le parole. Non è così: basta andare all’articolo 595 del codice penale per rendersene conto. Offendere l’altrui reputazione sarà pure un residuato del codice Rocco, ma è ancora una norma vigente e punisce chi parla male. La Costituzione italiana difende le opinioni, non gli insulti o le affermazioni false dette in maniera che potremmo definire ingiuriosa; ad ogni modo questi due casi non rientrano nella categoria delle opinioni.
Il secondo errore è estendere un ipotetico diritto di odiare alla conseguente espressione di quel diritto e agli effetti che esso genera. Si può tranquillamente odiare, e non ci sarebbe nemmeno bisogno di affermarlo, il problema è l’espressione di odio non l’odio. Posso ubriacarmi a casa mia, ma non posso essere molesto quando mi ubriaco per strada o in un locale. Faccio l’esempio non per dire che l’espressione dell’odio sia reato in sé, ma per ricordarci che sono due cose differenti.
Insomma queste critiche a #odiareticosta lasciano il tempo che trovano. Le prendiamo per quello che sono: provocazioni per il solo gusto di épater le bourgeois.
Invece, e qui purtroppo si registra una incomprensione sostanziale delle dinamiche che muovono la psicologia delle persone nei social network, altre critiche diventano radicalmente errate quando affermano che non si processano le emozioni. Intanto #odiareticosta non processa le emozioni come abbiamo visto ma l’espressione quando si ravvisa un reato.

Tuttavia cerchiamo di capire meglio qual è la dinamica con cui sgorgano le emozioni nello spazio digitale.
Uno dei confini che l’umanità ha attraversato, nella relazione con le techno-corporation, risiede proprio in una nuova modalità di manipolazione e quindi di espressione delle emozioni. Le emozioni che diciamo, scriviamo, sintetizziamo e stilizziamo nei social network, tanto per cominciare, sono emozioni nutrite dal design del social network stesso. Sono emozioni figlie della progettazione dell’algoritmo. Possiedono un alto coefficiente di contaminazione potremmo dire. Sono emozioni ibride, emozioni mixed, per usare un termine caro a Sherry Turkle, il che non vuole dire che siano fasulle ma contaminate appunto. Lo stimolo, il modo in cui le esprimiamo e le reiteriamo, la polarizzazione di cui le nutriamo, sono figlie di righe di codice scritte da ingegneri del software. Sono emozioni, in parte, programmate da altri. Dopotutto quella specie di punteggio che l’algoritmo del social network affida a un post (il cd. relevancy score) altro non è che un punteggio di emotività, tante più emozioni condensa e porta con sé un post, tanto più quel post avrà valore per il social network.
Se detta così suona strana, basta leggere qualche libro o intervista di progettisti pentiti di social network per riepilogare come stanno le cose. (Ve ne elenco qualcuno: “Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web” (piuttosto semplice ma buono per iniziare), “Scansatevi dalla luce“, “Hooked, Catturare i clienti“).

La verità è che le nostre emozioni finiscono per essere il prodotto di scarto di un sistema di ricompense variabili che ci inchioda ai social network. Ogni notifica, ogni commento, ogni attivazione del vostro smartphone viene generata affinché voi torniate a controllare lo stesso smartphone, per accertarvi che non ci siano nuove notifiche, nuovi commenti, nuove attivazioni. In un circolo che definire vizioso è poco. Di tutte le notifiche che ricevete, buona parte sono l’effetto di una specie di festival del surrettizio che gli algoritmi mettono in piedi per distrarci e farci tornare ad aprire le applicazioni. La guerra per l’attenzione che le techno-corporation combattono ogni giorno, non è soltanto una guerra per leggere qualcosa o comprare qualcosa, è anche un conflitto continuo per spingerci a dire qualcosa. Ogni nostra affermazione – indipendentemente dal modo in cui la diciamo – concorre a precisare il nostro identikit digitale. Più reagiamo, più esprimiamo le nostre emozioni, meglio è definito il nostro identikit per i sistemi di business manager con cui si gestisce l’advertising digitale.
Il problema insomma non è “spegnere l’interruttore e diventare d’un tratto una persona priva di odio”, ma proprio l’esatto contrario. Ovvero l’impossibilità di spegnere l’interruttore, sganciarsi dagli apprendisti stregoni dei social network che giocano con la nostra dopamina e realizzare l’opt out, e cioè l’impossibile uscita dallo spazio digitale. L’impossibile disconnessione.

Ogni emozione la esprimiamo perché il social network per primo ce lo chiede. Non chiede un pensiero, un ragionamento, un’analisi, chiede una stilizzazione delle emozioni. Le emoji svolgono esattamente questa funzione. Una delle possibile faccine è quella che esprime rabbia, oppure odio. “Artifacts have politics?” si chiedeva Langdon Winner nel 1980, certo che sì, gli artefatti anche quelli digitali, hanno conseguenze politiche, sociali. E quando qualcuno, un leader politico, decide di pubblicare un post sponsorizzato lo fa per generare una reazione. Deve solleticare una risposta emotiva, e per capire se quel che pubblicherà funziona o meno, dovrà sottoporlo a una specie di test Voight-Kampff, il test di Blade Runner per capire se chi abbiamo davanti è un replicante oppure è un essere umano, cioè portatore di emozioni. Se il post supera l’esame, ed è ben confezionato, può essere sponsorizzato per moltiplicare quelle emozioni su scala pressoché globale.
Sapete qual è una delle reazioni che è possibile stimolare quando si mettono 10€ su un post su Facebook? La cosiddetta “interazione” e cioè la possibilità di “raggiungere le persone più interessate a interagire con il tuo post. Le interazioni comprendono i “Mi piace”, i commenti e le condivisioni…”. Queste sono le emozioni artefatte, stimolate, dopate. Utilizzate l’aggettivo che preferite ma la sostanza è che sono un riflesso condizionato attivato da un software. Sono in parte inautentiche, in parte no, ma solo perché le diciamo noi. Tema un po’ più complicato del rivendicato diritto a odiare.
Aggiungo che la difesa di un sentimento importante come l’odio andrebbe messa a miglior partito, andrebbe difesa in luoghi altri e rispetto a modalità di ingaggio altre; non vale la pena difendere l’odio in uno spazio in cui le manovre del nostro io e del nostro inconscio sono sballottate e orientate da da miliardi di righe di codice. Inoltre la modalità con cui l’odio si esprime ha una portata mai vista in precedenza nella storia dell’umanità, per una banale e purtroppo dimenticata questione di numeri. L’essere umano doveva assistere a un’adunata oceanica di quelle riprese da Leni Riefhenstal per vedere tanta gente odiare con tanta solerzia ed energia, l’essere umano doveva trovarsi davanti alla Bastiglia, il 14 luglio del 1789, per assistere a una enorme quantità di odio ben incanalato. Ed era, ricordiamocelo, un odio che alla fine ha prodotto un esito.
Questo odio qui è un odio espresso ma, almeno fin qui, frustrato, un odio senza esiti. Sempre che consideriamo senza esiti il vento del consenso che gonfia le vele del risentimento e della chiusura, quel vento del consenso che lascia alla deriva e senza soccorso barconi colmi di uomini disperati, che incrinano la prioritaria purezza delle emozioni di un intero popolo. Questo odio espresso e senza azione, fin qui senza azione, nutre una enorme riserva di pulsioni sublimate, una riserva che cresce mostruosamente e sta lì. Giace nei server dei social network per essere analizzata, misurata, studiata e per fare oggetto di advertising. E per creare una ulteriore riserva di odio.
Forse giova ripetere che mai nella storia dell’umanità abbiamo avuto la possibilità di accedere all’espressione di sentimenti da parte di milioni di persone in diretta, con immediatezza come oggi; mai abbiamo avuto la possibilità di essere partecipi di tanto odio, di leggerlo, di assorbirlo, di viverlo, di farci attraversare da tutto questo odio con rapidità e continuità. Mai.
E solo un ingenuo può pensare che tutto questo odio al quale siamo esposti non abbia un qualche effetto su di noi. Evito di trascrivere la letteratura scientifica che racconta gli effetti perversi sullo stato d’animo delle persone esposte ai social network. Un’esposizione – a proposito di contaminazione – che ricorda quella alle radiazioni, tanto è potente. Ed evito pure di elencare i resoconti giornalistici che raccontano la pesantezza di chi per lavoro ripulisce la sentina del web. C’è un documentario che si chiama The Cleaners per chi vuole farsi un’idea.
La provocazione è una nobile arte, utile spesso e talvolta pericolosa. Questo è un caso in cui i rischi sopravanzano l’appetito per le belle parole. Non bisogna scherzare con quelle riserve di odio accumulate in forma di bit, non vanno difese, nemmeno per il gusto di farlo. #Odiareticosta è un esperimento sensato, intelligente, di chi ha colto la grammatica dello spazio digitale. Non va depotenziato soltanto per per un esercizio di stile, per scrivere un articolo brillante. La brillantezza lasciamola alla conversazione de visu, senza Spritz, con un bicchiere di vino, tra poche persone e con gli schermi degli smartphone rivolti verso il basso.