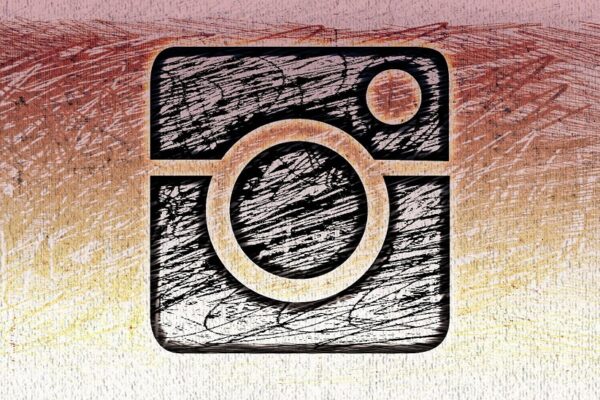La notizia non è splendida. Eppure è una notizia, e come tale andrebbe data.
Nel 2019, secondo eMarketer, la pubblicità digitale negli Stati Uniti supererà la pubblicità tradizione su giornali, tv e radio. Sul podio più alto del mercato pubblicitario ci sono gli annunci digitali, un podio che vale 129 miliardi di dollari.
E ovviamente i player di questa rivoluzione copernicana (termine ben meditato) sono soprattutto Google e Facebook, il primo arriverà a una quota del 37% dell’intero mercato pubblicitario digitale, il secondo al 22%, il terzo posto è conquistato da Amazon che, nel 2019, otterrà poco meno del 10% del totale.
Uno scenario che peserà in maniera determinante sui modelli di business della stampa tradizionale e online. Anche perché le techno-corporation non solo hanno sottratto risorse importanti, ma – questo è l’elemento decisivo – hanno inclinato il piano da cui i cittadini si abbeverano di notizie. Google e Facebook sono diventate, insieme a molte altre cose, il luogo in cui le notizie circolano, lo spazio in cui i contenuti nella loro multiforme essenza circolano. Spazi di informazione accanto ai giornali, sempre più dei giornali.
Parliamo di aziende che non hanno alcun interesse a fare giornalismo, ad assumere giornalisti, a produrre notizie, perché il concetto di notizia lo hanno letteralmente scarnificato, riducendolo all’osso.
Tuttavia, per la loro semplice esistenza in vita, una delle principali fonti di reddito dell’industria editoriale andrà prosciugandosi. Alla carta stampata, alla radio e alla tv non rimarrà che un ruscello, avendo le techno-corporation deviato il corso del fiume principale. Nel 2021, stima eMarketer, le proporzioni negli Stati Uniti saranno queste: il mercato della pubblicità digitale varrà 172 miliardi di dollari contro i 104 di quella sui media tradizionali.
Sempre in questo scorcio d’anno alcune notizie contraddittorie inducono a riflettere su un processo che è tutt’altro che scontato. Il New York Times ha comunicato che, nel 2018, gli abbonamenti digitali sono cresciuti del 27% e i ricavi sempre da digitale hanno raggiunto quota 700 milioni di dollari. Il tutto sospinto dalla sola presenza di Trump alla Casa Bianca. Il Presidente sembra essere il vero promoter della stampa liberal americana, online e offline. Negli ultimi due mesi alcune testate online hanno ricevuto schiaffoni dal mercato e hanno dovuto licenziare. Non siti qualunque, parliamo di Buzzfeed, Vice e Verizon.
Da noi tutto si complica: non abbiamo un mercato ampio come quello di lingua inglese o spagnola. Il NYT vende in tutto il mondo, così come l’Economist, El Pais o il Wall Street Journal.

Aggiungiamo un argomento al dibattito assai frequentato sul rischio di scomparsa dei media tradizionali, e cioè la Sindrome di Stoccolma dei giornali per tutto quando proviene dalla Silicon Valley. Sindrome attenuata dopo lo scandalo Cambridge Analytica, ma comunque una sindrome che ha prodotto effetti nefasti e ne produrrà ancora. Per anni molti giornalisti hanno glorificato l’innovazione che arrivava dalle techno-corporation, lucidando ogni singola iniziativa di una patina lucente di cambiamento e riducendo all’osso l’energia critica per smontare quanto c’era da smontare. In primo luogo l’assunto che Internet fosse sinonimo di quelle aziende e che quelle aziende rappresentassero l’essenza pura del web.
Nella loro marcia trionfale verso l’onnipotenza globale, le techno-corporation stanno guadagnando quantità di denaro immani e stanno rastrellando le ultime risorse disponibili tra quelle necessarie alla sopravvivenza della stampa.
Facebook e Google però vanno considerate per quello che non sono, non sono cioè media company. E pur non essendo media company, rappresentano l’essenza cristallina della concorrenza alla stampa. Non lo dicono, non lo sbandierano, non se ne vantano, eppure lo sono fino in fondo.
Delle notizie a Google e Facebook non importa nulla, del giornalismo non importa nulla, dei giornalisti non importa nulla. Così come non gli importa nulla della funzione del giornalismo nelle società e nelle democrazie. Sono nerd e per quanti consulenti di Pubbliche relazioni possano assumere, pensano da nerd. Si tratta di un peso, di una specie di obbligo cui devono assolvere: «quasi tutti i tecnici – scrive Eli Pariser in un testo fondamentale, Il Filtro – rifiutano l’idea che il loro lavoro abbia conseguenze morali o politiche. Molti sono convinti di essere interessati solo all’efficienza e alla progettazione, a costruire bei programmi, non a confuse dispute ideologiche e ipotetici valori».
Le notizie – per loro – sono contenuti come le favole, i video comici, le bufale e le parabole.
La verità è che la notizia del sorpasso della pubblicità digitale ai danni di quella tradizionale è una notizia ferale. Che accelera il processo di smantellamento di una parte consistente dell’industria editoriale tradizionale. Certo l’industria editoriale ha molte colpe, ma la colpa dell’onnipotenza conclamata delle techno-corporation non può gravare solo sulle sue spalle. La responsabilità va divisa con quel soggetto indistinto che un tempo chiamavamo opinione pubblica, con la politica, con il mondo economico e con l’industria culturale.
La sottovalutazione degli effetti personali e psicologici, sociali e politici delle techno-corporation è stata, ed è tuttora, merce diffusa. E tra queste, va sottolineata la consapevolezza dell’effetto devastante del tempo trascorso online dalle persone a fare molte cose, compreso l’informarsi in maniera discontinua e frammentata. Non si vede gran luce all’orizzonte per superare la dipendenza dall’oggetto smartphone come strumento informativo. Anzi, le idee sono poche e confuse: ieri ho letto un tweet nel quale un tizio proponeva un modello di business per i giornali “molto innovativo”. Il tizio, in questione affermava in una bella slide in inglese che i giornali per vendere devono puntare “sulla qualità a scapito della quantità, sul valore dell’ascolto e del giornalismo come servizio” e, infine, sul “product-first”. Mai tante banalità in così poche righe, e mai così tanto slegate dall’idea di un modello di business; faccenda più seria e difficile da mettere in piedi.
C’è un problema assai complicato ed è quello di scovare persone che paghino per il prodotto giornale. Per un prodotto in lingua italiana quindi letto da poche persone, e che superi la prima e più eminente risposta data in una ricerca di mercato, da chi ha deciso di acquistare un quotidiano: il senso di colpa. Il profondo senso di colpa per non aver letto il quotidiano, per non averlo nemmeno sfogliato, per essersi soffermato – al massimo – alla prima pagina.
E su questa faccenda del tempo sarebbe bene che i giornali e la stampa in generale facessero una battaglia che arriva prima di qualunque modello di business. Una battaglia che ponga come centrale il tema del tempo da dedicare all’informazione, all’approfondimento, alla comprensione e all’interpretazione del presente. Su una giornata composta da 16 ore di veglia, 6 ore le dedichiamo a stare connessi, e di queste 2 ore a stare sui social network.
Purtroppo dobbiamo dire addio alla splendida massima di Hegel: la lettura dei quotidiani non è più la preghiera dell’uomo moderno.
Accendiamo il talismano-smartphone per rivolgere la nostra quotidiana preghiera agli oracoli tecnologici: interroghiamo il motore di ricerca e ci rivolgiamo ai social network. E a nulla vale dire che lì dentro abitano anche le notizie. Sono notizie affogate, annaspano senza ossigeno, mescolate a molto altro.
Forse è necessario ricordare che le notizie non sono i giornali.
Un giornale è un oggetto complesso: oltre alla notizia in un giornale vive una chiave di lettura, uno sguardo su un paese e sul mondo; il lettore trova contenuti di spalla che integrano, interviste che ampliano la vista e l’orizzonte interpretativo di un fatto, opinioni e approfondimenti.
Il lettore trova soprattutto una prima pagina, quella gerarchia delle notizie che lo “costringe” a confrontarsi con quanto accade di importante intorno a lui.
Sempre citando Pariser: «mentre un tempo bisognava comprare tutto un giornale per leggere la pagina sportiva, adesso si può andare su un sito web che si occupa solo di sport e ogni giorno offre più contenuti di dieci giornali».
Le notizie, nel social network e in qualunque aggregatore, si riducono a testi senza alcun legame con il contesto, con la sostanza delle cose, senza alcuna connessione con altro che non sia un articolo correlato pubblicitario.
Sarebbe bello che l’industria culturale nel suo complesso, e i giornali per quanta possibilità ancora hanno di esercitare influenza, dedicassero un po’ di tempo ed energie a combattere per la loro stessa sopravvivenza.
Potrebbero dedicare la stessa attenzione e la stessa splendida solerzia che dedicano alla forma fisica, alla cura del corpo, alla salute, a spiegare che è altrettanto salutare e vitale allenare il nostro cervello a leggere notizie, a sforzarsi di comprendere il presente. A fare tutto questo in un oggetto che ha maggiore densità, elementi di contesto e di analisi di un link in un rullo che scorre. Il contenuto informa come può informare una particella elementare che vagola in attesa di un’attenzione libera da altre costrizioni, e dunque vagola in attesa di un essere umano che, tra un gattino e un’imprecazione contro i migranti, vi dedichi il tempo minimo e indispensabile a coglierne il significato di base.
(Se non l’avete ancora fatto, potete iscrivervi al Canale Telegram di Disobbedienze cliccando su questo link >>>> https://t.me/joinchat/AAAAAFHvQcfh8rguTXnUhQ )