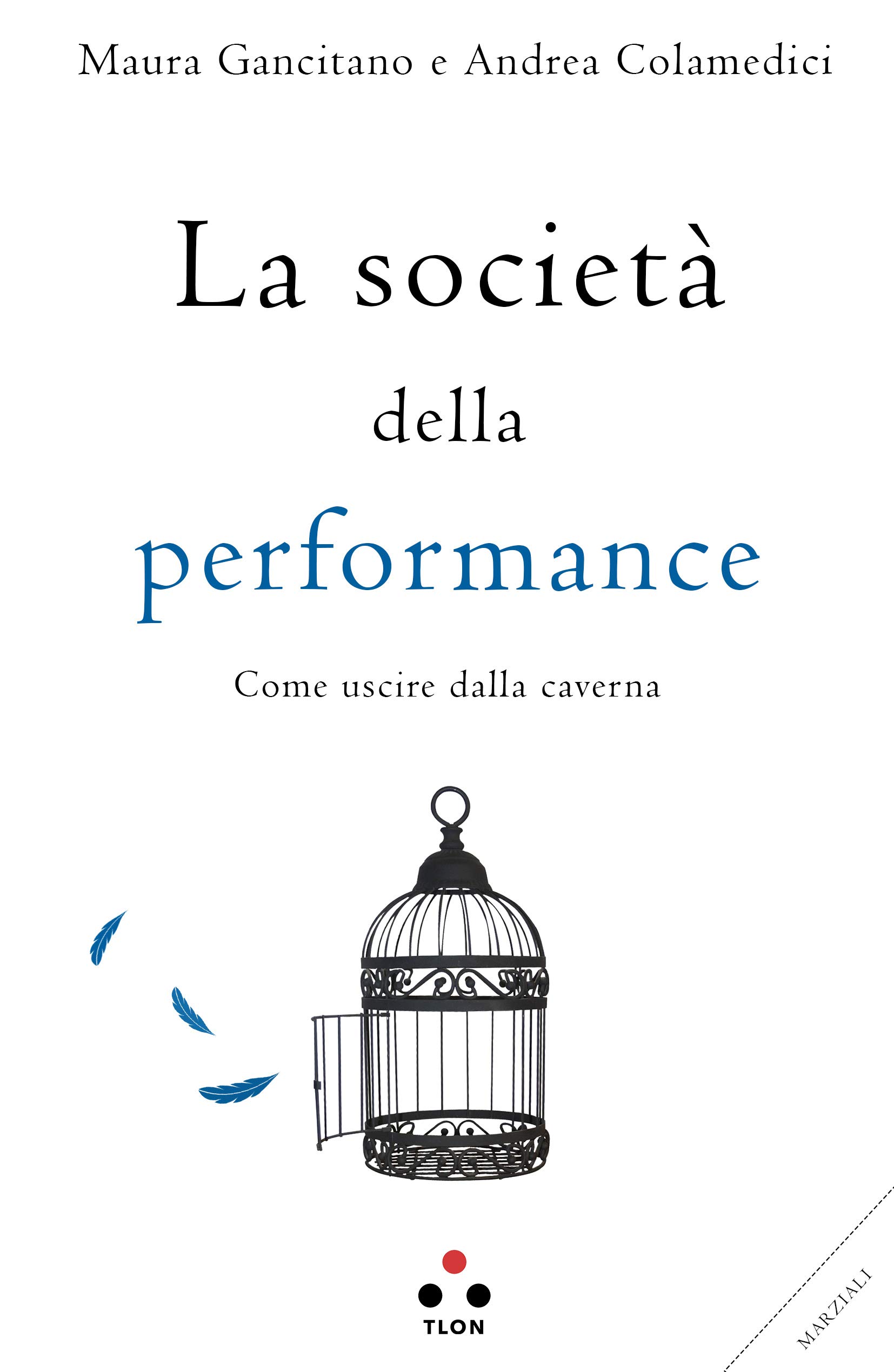Ravelstein è una delle ultime fatiche del premio Nobel per la letteratura Saul Bellow. Non so dire se sia il suo miglior romanzo, di sicuro è un ottimo romanzo, almeno nella prima parte. Il ritratto di un grande intellettuale, Abe Ravelstein, giunto al termine della sua vita. Un ritratto che compendia le sue letture e le sue passioni, le idiosincrasie e i vezzi, un romanzo di storia delle idee e soprattutto un romanzo che tratteggia un modo elitario, splendidamente elitario, di intessere relazioni culturali e personali. Il racconto è costruito come un dialogo tra il narratore, uno scrittore di successo di nome Chick, e il protagonista che gli chiede di scrivere la sua biografia. La narrazione si snoda tra alberghi di lusso a Parigi, un appartamento di Chicago, l’Ospedale dove il protagonista viene ricoverato, ovviamente i campus universitari, e si arricchisce di digressioni sull’Olocausto e riferimenti a Platone, Socrate, Rousseau, Macchiavelli che formano la trama con cui Ravelstein legge il presente. Saul Bellow era amico di Allan Bloom, filosofo e autore del formidabile saggio “La chiusura della mente americana”, e proprio a Bloom si è ispirato per il personaggio di Ravelstein. Il protagonista così come il modello in carne e ossa è un docente di filosofia politica, divenuto celebre e ricchissimo grazie al successo planetario di un suo libro. Forse nella parte finale la scrittura si appesantisce, ma la prima parte del romanzo è formidabile, nitida e giocosa; aver scritto quelle prime 150 pagine per Bellow dev’essere stato un vero spasso.

Ravelstein appartiene alla categoria degli Stoner e dei Pnin, una categoria immaginaria di docenti universitari americani che escono dai canoni, incarnano veri outsider e in virtù delle loro idiosincrasie assurgono a vette di somma intelligenza, di assoluta comicità e cristallino disincanto, e di drammatica tenerezza. Vanno tutti e tre oltre la classica definizione di protagonisti di “campus novel”, non fosse altro che per qualità e limpidezza nello stile degli scrittori che ce li hanno fatti conoscere.
Ravelstein è chiaramente più cinico di Stoner e meno poetico di Pnin, più saggio e scafato di entrambi, Saul Bellow lo tratteggia come un manipolatore colto e sentimentale, come uno che definiva «il nichilismo americano» un «nichilismo senza l’abisso».
Le somiglianze tra Pnin e Ravelstein sono molteplici e risiedono nelle radici culturali europee, nella mostruosa erudizione e nella leggerezza con cui i due autori lasciano che questa erudizione si spanda e si annidi via via nelle pagine, facendo acquisire al romanzo la super-categoria di “libro di libri”, e cioè di volume che ne spinge a leggere altri, da “La chiusura della mente americana” al “Simposio” di Platone, dal “Principe” alle memorie di John Maynard Keynes.
La differenza più evidente sta invece nel potere che Ravelstein intercetta nella sua essenza e coglie alle origini, un potere studiato ed esercitato, rispetto al quale il professore svolge una funzione maieutica. I suoi ragazzi, «i ragazzi di Abe», dopo aver appreso da lui la sostanza di quella cosa chiamata potere, adesso risiedono a Washington, lavorano alla Casa Bianca e al Dipartimento di Stato, e lui li sente al telefono, tutti i giorni per sapere come vanno le cose da quelle parti.
Il personaggio di Bellow somiglia al dotto, eccentrico, consigliere di un principe italiano del 500, potrebbe averne lo spessore, le manie, il gusto per le citazioni classiche e lo sguardo al passato come chiave privilegiata di interpretazione del presente.

Se Stoner illanguidisce il lettore e Pnin lo diverte, Ravelstein si propone come mito e modello, un esempio di docente par excellence. Essere umano di somma risolutezza che ordinava, come prima cosa, ai suoi studenti di dimenticare le famiglie di provenienza; dimenticare i padri «bottegai di Crawfordsville, Indiana, o di Pontiac, Illinois», affinché i figli potessero pensare a lungo, e così intensamente, alla Guerra del Peloponneso, al Simposio e al Fedro da non trovare «per nulla singolare il fatto di avere, ben presto, più familiarità con Nicia e Alcibiade che con il giro del lattaio o il grande magazzino sotto casa».
Una tale premura didattica, si vedrà nel romanzo anche con risvolti ossessivi, una simile dedizione alla cultura, una idolatria dell’intelletto è oggi così fuori scala, così lontana dai paradigmi del presente che giustifica appieno la presenza – oltre alla grafomania di chi scrive – di questa recensione qui dentro. In epoca di dileggio dei professoroni chiunque essi siano, un docente è una creatura da preservare come farfalla rara, con tutte le sue bizzarrie, i colori e i voli pindarici che impreziosiscono le sue lezioni, se ha come obiettivo quello dell’educazione dei ragazzi.
Ravelstein era, e potrebbe tuttora essere, un modello radicale di docente; un professore che, dopo averli costretti a dimenticare i padri, ricordava «agli studenti che erano venuti all’università per imparare qualcosa, e ciò significava che dovevano disfarsi – anche – delle opinioni dei loro genitori. Li avrebbe indirizzati verso una vita più nobile, ricca di varietà e diversità, governata dalla razionalità».
Bellow conduce il suo personaggio oltre la rappresentazione di Allan Bloom e gli fa dire che «avrebbe fatto loro il dono più grande che potessero sperare di ricevere e li avrebbe guidati attraverso Platone, li avrebbe introdotti agli esoterici segreti di Maimonide, avrebbe insegnato loro la corretta interpretazione di Machiavelli, la più alta umanità di Shakespeare, fino a Nietzsche e oltre. Non era un programma accademico, il suo, era a ruota libera».
In questo nostro presente un vaste programme come quello di Ravelstein aiuterebbe a ridurre il numero esorbitante dei cretini. Basterebbe pensare ai tanti che oggi, con una certa solerte fierezza, annotano la frequentazione ai corsi di laurea nella cosiddetta Università della vita, nei loro profili all’interno del social network.

Saul Bellow già nel 2000 ricordava che esisteva un tempo in cui viveva ancora «una notevole comunità letteraria, (…), ma oggi in una città americana non puoi più sperare di discutere dei romanzi di Stendhal o delle poesie di Thomas Hardy con medici, avvocati, uomini d’affari, giornalisti, politici, personalità televisive, architetti o commercianti».
Quanta verità in un’affermazione di quasi vent’anni fa; la persona che mi ha suggerito di leggere questo romanzo, che ringrazio e ringrazierò sempre del suggerimento, e per molto altro, è un Professore che condensa modernità e cultura d’altri tempi, è una delle poche persone con cui riesco a discutere – fingendo di lavorare – per un’ora buona di classifiche Manniane, cercando di capire se sia meglio la Montagna Magica, il Doctor Faustus o i Buddenbrock. Passatempo ormai scaduto, e considerato dal prossimo l’equivalente nella conversazione di quelle orribili sfilate in costume che allietano i pomeriggi estivi delle contrade italiane.
Bellow prosegue e svela altre connessioni magiche con il presente, e fa dire a Ravelstein: «ogni tanto t’imbatti in un lettore di Proust o in un matto che ha imparato a memoria pagine intere di Finnegans Wake. Io amo dire, quando mi chiedono di Finnegan, che me lo tengo per la casa di riposo. Meglio entrare nell’eternità in compagnia di Anna Livia Plurabello che con i Simpson scatenati sullo schermo del televisore». Magari fossero solo i Simpson!
Qui ci tocca entrare nell’eternità circondati da gioiosi zelanti che fotografano su Instagram nature morte, per lo più tazze, coperte e taccuini intonsi, nelle infinite tonalità di bianco che il Pantone offre ai mortali, e talvolta si ritraggono essi stessi insieme alle nature morte in una gamma sconfinata di odiosi e irreali colori pastello. Riducendo questa becera pratica a una sorta di neo-Canone del carino in cui tutto brilla e splende, la positività regna sovrana; quando in realtà, spiega un articolo del Guardian dello scorso 17 settembre, tutto questo rende le persone infelici. Profondamente infelici, dacché si rendono conto che quel biancore è sinonimo di falsità, falsità inimitabile e irraggiungibile. Subiamo un incupimento generalizzato derivante dallo splendore che circonda ogni cosa, ogni posa, ogni natura morta con persona che spesso viene definita selfie.

Fa dire Saul Bellow al narratore, che è molto più la voce dello scrittore di quanto non lo sia il protagonista stesso: «il bel tempo peggiora le cose», quasi tutti i filtri di Instagram sembrano patine applicate al cielo per trasformarlo e renderlo di un’altra stagione; proprio «la patina che il sole mette sul paesaggio – spiega Bellow -, il trionfo della vita, per così dire, il rigoglio di ogni cosa mi precipita nella disperazione. Non sarò mai all’altezza della massa di tutte queste ore di vita trionfante». Non sarà il miglior romanzo di Bellow ma una frase come questa vale, allora e oggi, il prezzo di copertina.