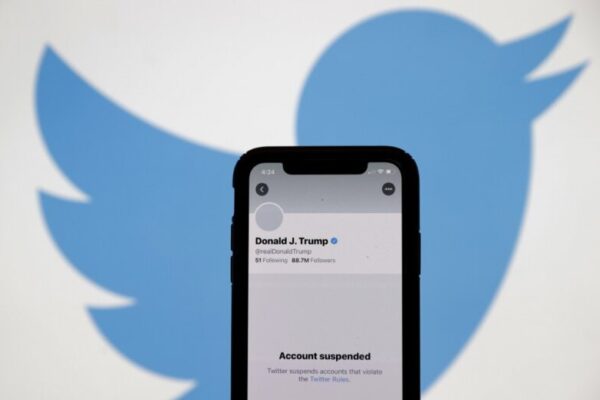Ho visto questa foto di Pier Paolo Pasolini e sono sprofondato nei ricordi. Testaccio non è il mio quartiere ma l’ho attraversato in diverse stagioni della vita.
Ricordo con nitidezza quando al Monte dei cocci si accedeva con facilità, non esisteva un cancello: i romani prendevano da terra i colli delle anfore e li usavano per fermare le porte, o per farne un posacenere, si saliva ed era una scarpinata in cui scivolavi su strati millenari di monnezza, vedevi quelli che andavano affà cicoria; il gazometro si alzava e abbassava sulla pressione del metano, ed era un’attrazione di tecnologia e magia, e Pierino, proprio lì sotto al gazometro, in un buchetto con le luci al neon, preparava rigatoni al sugo di involtini che la moglie serviva agli operai dell’Italgas, e tutto questo avveniva prima che il tremore del Parkinson rendesse pericoloso quel gesto, tremore e pericolo che nessun avventore oltraggiava e anzi correva il rischio che finissero rovesciati senza fiatare, senza parlare, senza scriverne chissà dove; ricordo quando davanti al Monte dei cocci c’era Spazio Zero, dove oggi c’è un parcheggio, ed era un teatro tenda vivo e del quartiere; ricordo che c’erano delle roulotte ed erano abitate, abitate da esseri umani, da ragazzini molto simili a quel ragazzino, dal caschetto vaporoso, intervistato da Silvano Agosti nel pasoliniano D’Amore si vive; ricordo poi quando il Mattatoio venne aperto ai cittadini e i primi racconti truculenti di chi aveva lavorato per una vita lì dentro, e conservo impressa l’immagine di questo piccoletto di mezza età, con una specie di riporto e un impermeabile più lungo del giusto, che mostrava ganci, binari e canali di scolo del sangue a noi che eravamo andati in visita, ricordo un’ombra di fierezza nel suo sguardo, una fierezza che si manifestava per la primissima volta; forse c’era ancora odore di bestie morte ma questo non lo ricordo; il mercato è poco distante, e per me è soprattutto un ricordo estivo: da ragazzino sapeva di profumi di basilico e pomodori, profumi che coloravano la stagione degli ultimi collegi docenti di mia madre e permeavano quell’infinito festoso preludio alle vacanze che era il mese di giugno; ricordo, e pesco nei racconti di mamma, che dal tecnico odontoiatrico De Amicis, confinante con la sua scuola, ogni tanto partivano fitti lanci di calchi di dentiere, una pioggia di calchi bianchi piombava sui più piccoli che giocavano a pallone nel cortile delle medie e scappavano per non rischiarne una in testa; a fine anno immagino il bidello con la scopa che, indolente ma non stupito, raccoglieva quella distesa di finte protesi, di morsi mancati, di ambizioni professionali e compiti in forma d’esercitazione, raccoglieva tutto questo e lo gettava dentro al secchione nero della Nettezza Urbana di Roma, scuotendo la testa davanti alla fabbrica dei finti molari, davanti a un cimitero di modelli che non si sarebbe mai fatto opera.
Per cinque anni, poi, ho rivisto quello stesso mercato da una finestra sulla piazza, prima che lo trasferissero per ragioni di igiene, di gusto, di decoro e pulizia altrove; allora ho dovuto confinare l’alba nella memoria, l’alba vista da lassù, dalla finestra, insieme ai pensieri di quell’epoca turbolenta, e all’immagine dei macellai con lo zinnale bianco, macchiato di rosso sangue (ancora il sangue), con il berretto di lana e una specie di parannanza sulla spalla dove andavano caricati due quintali di manzo, i macellai scaricavano interi quarti dai furgoni frigo avvolti, e tutto questa vita avveniva prima che il mercato prendesse vita e voce.

Questa foto di Pasolini scatena ogni ricordo di Roma e una nostalgia banale di un mondo perduto, e le chiacchiere circa una città che non esiste più.
In realtà mi viene in mente un ragionamento intorno al cosiddetto Paradosso dell’immunità, che fa sì che bambini non esposti ad agenti infettivi da piccoli, poi possano contrarre asma e altre patologie, da adulti. Quegli agenti rinforzano il loro sistema immunitario (la faccio breve ché non è il mio campo).
Più che a Pasolini penso soprattutto a Roma, e a un amico caro il quale scrive che non è così convinto che le città abbiano un’anima. Ecco forse, caro Luca, le città non hanno un’anima tuttavia il loro sistema immunitario può deteriorarsi rispetto ad alcuni agenti patogeni. Se le consideriamo organismi, e non dubito lo siano, forse possiamo pensare che abbiamo raschiato via, insieme allo sporco, la superficie viva delle cose, lasciando un’altra banale seppure tossica sporcizia di superficie e creando una feroce contraddizione. Pur condividendo buona parte del ragionamento di Tamar Pitch sul decoro, e non condividendo l’abuso che si fa del suo discorso, penso che lo sporco di superficie, la monnezza, ci abbia reso intolleranti, quasi in senso clinico, allo sporco e tuttavia ci abbia abituato ai rifiuti. E penso che, allo stesso modo, il nuovo pulito, una certa ossessione del pulito rappresentata alla perfezione dai mercati dipinti di bianco e senza più grida, ci abbia reso allergici ai nuovi brutti sporchi e cattivi che non vivono più nelle baracche a Valle Aurelia, sopra la ferrovia. Come se la nostra memoria immunologica delle persone e delle cose, a forza di esternalizzarla, sia andata in corto circuito. E oggi siamo allergici a tutto. A quello cui è giusto essere allergici, e a quello che no, non merita la nostra allergia.
(Ci sarebbe molto altro da scrivere).