Qualche giorno fa una cara amica mi ha raccontato il modo in cui sta facendo smart working. L’azienda per la quale lavora pretende che, durante tutta la giornata lavorativa, lei tenga accesi e funzionanti webcam e microfono. Anche quando si alza, va in bagno o risponde a una telefonata. In questo modo sappiamo sempre quello che fai, questa la conclusione, come se fossi in ufficio.
Non è solo l’azienda in cui lavora la mia amica a pensarla così. Un ministro del governo di Boris Johnson ha dichiarato al quotidiano The Times che «ci deve essere il sospetto che alcune persone abbiano trascorso gli ultimi 15 mesi a lavorare da casa, ma in realtà non abbiano fatto molto». Giudizio diffuso che tuttavia il Financial Times ha criticato: «se dopo 15 mesi hai solo un “sospetto” su ciò che sta facendo la tua gente e trovi “difficile sapere” chi sono i tuoi migliori dipendenti, sei colpevole di negligenza nel migliore dei casi, cattiva gestione nel peggiore».

Raghu Krishnamoorthy autore di “The Future of Working”, popolare newsletter su LinkedIn, aggiunge una considerazione a proposito di come molti manager hanno affrontato il remote working: «un “manager” è tanto un costrutto sociale quanto organizzativo. Lavorare dal tavolo della cucina non è proprio uno stimolo per l’ego, (…) sei solo un altro volto su Zoom con uno sfondo virtuale inventato per oscurare il caos intorno a te. E quando il lavoro diventa virtuale, lo status manageriale svanisce».
Se queste sono le premesse, il futuro del remote working comincia a farsi piuttosto fosco.
Ci sono molte resistenze a strutturare il lavoro da remoto, sebbene la quasi totalità delle ricerche fatte in questi mesi abbiano confermato il desiderio dei dipendenti di andare avanti, di proseguire garantendo un equilibrio tra occupazione da casa e la presenza in ufficio.
Cosa piuttosto semplice a dirsi, meno a farsi.
Sapevamo lavorare dall’ufficio prima della pandemia, abbiamo imparato a lavorare da casa, adesso dobbiamo inventarci un lavoro ibrido, un po’ qui e un po’ lì, cosa che non è affatto semplice.
Sul New Yorker, Cal Newport ha scritto che c’è bisogno di un investimento che ha a che fare con la cultura organizzativa delle imprese: «devi cambiare la definizione stessa di “lavoro”, allontanandolo dalla sorveglianza e dall’attività visibile verso risultati definiti e fiducia. Un cambiamento culturale di questa portata richiede la riqualificazione di dipendenti e dirigenti a ogni livello», e anche così facendo non è detto che i risultati arriveranno.
Non esistono solo le critiche che arrivano dai manager. Le indagini sul lavoro da remoto evidenziano sempre, accanto a un aumento della produttività, un senso di isolamento nella quasi totalità delle persone. Non tutti poi hanno equilibri familiari che consentono una gestione accettabile del remote working, in molti casi andare a lavorare significa anche scappare.
Più in generale credo che avremo bisogno di un passaggio generazionale: le resistenze al remote working diminuiscono in chi mostra una maggiore facilità a gestire relazioni, in ogni ambito, all’interno dell’ecosistema digitale, con tutte le difficoltà del caso. Le relazioni che prendono corpo qui dentro sono pur sempre relazioni, ma le definirei relazioni diminuite, anche quelle professionali.
Tuttavia a queste prime riflessioni, vorrei aggiungere un elemento di complicazione.
Ritengo che se potessimo antropomorfizzare il capitalismo, diremmo che il giorno in cui il capitalismo realizzerà che nel remote working il semplice concetto di giornata lavorativa è un residuo del passato, un oggetto superato e di fatto inapplicabile, non ci sarà più spazio e tempo, e modo, per immaginare forme di lavoro differenti, ovviamente per le professioni che possono accedervi.
La convenienza del capitalismo rispetto a questa modalità organizzativa risiede in un concetto semplice: da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire, il nostro lavoro ci segue e ci accompagna, grazie allo smartphone. Il lavoro è sempre con noi, oltre le otto ore canoniche.
È chiaro che la soluzione scovata dall’azienda in cui lavora la mia amica, webcam e microfono sempre accesi, riporta a un meccanismo di controllo che torna indietro rispetto alla direzione che la tecnologia suggerisce, che la tecnologia ci spinge a seguire (il verbo è to nudge).

Secondo alcuni sondaggi statunitensi l’80% delle persone controlla il proprio smartphone entro dieci minuti da quando si è alzata, mentre il 44% lo fa mentre è ancora a letto, nel caso dei millenial quest’ultima cifra sale al 66%. Infine il 70% degli intervistati afferma serenamente di dormire insieme al telefono.
Sono numeri che non sconvolgono nessuno, giacché ci comportiamo tutti in questo stesso modo, minuto più, minuto meno, abitudine più lasca o più stringente.
Ecco perché quando il capitalismo fatto persona capirà che dormiamo con la scrivania sotto al cuscino, e ci sediamo virtualmente alla stessa scrivania non appena svegli e ancora in pigiama, non avrà alcun dubbio, e lascerà redini libere al lavoro da remoto. Così il residuo otto-novecentesco della giornata lavorativa di otto, o più ore, svanirà in breve tempo (sempre che non sia già svanito). Con i nostri impegni professionali che ci seguono in ogni luogo, e in ogni tempo, servirà trovare una modalità per fissare cardini intorno ai quali far ruotare risultati e obiettivi. Risolto questo problema, il fattore giornata lavorativa diventerà presto un ricordo.
Dopotutto, qualche tempo fa, un altro amico mi ha confessato che «in fondo (lavorare 10 ore al giorno) è quello che facevo prima, solo che adesso lo faccio da casa».
L’estensione dei tempi di lavoro è un fatto connesso all’utilizzo dello smartphone, al modo in cui è progettato e al modo in cui, soprattutto, sono progettate le applicazioni che utilizziamo: tutto è costruito per carpire la nostra attenzione, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire. Poche cose sono rilevanti nel presente come la continua, reiterata e ingegnerizzata guerra alla nostra attenzione.
E il lavoro è un attore in questa guerra dell’attenzione, non necessariamente il più forte o quello vincente. Le mail dell’ufficio competono con le notifiche relative alle relazioni private, ad altre mail o messaggi, e poi con le notifiche dei servizi che utilizziamo, dall’intrattenimento al commercio.
La pervasività temporale e spaziale di questo processo rende il lavoro un competitore come un altro nella cosiddetta attention war.
Se accettiamo queste premesse dobbiamo ammettere con noi stessi quanto sia ridicolo il concetto di diritto alla disconnessione. Un diritto debole di fronte a una tecnologia forte, l’espressione di una fragilità normativa che si scontra con una progettazione che utilizza tecniche di neuromarketing, molto più solide di qualsiasi articolo di legge.
Non veniamo sollecitati a rispondere a una notifica perché essa ha a che fare con il nostro lavoro, ma perché una qualsiasi notifica induce e produce uno stesso identico risultato: aprire e controllare il telefono. La notifica chiede di alzarci, di interrompere quanto stiamo facendo e di verificare il contenuto della notifica stessa. In alcuni casi, addirittura, crediamo che il nostro cellulare stia vibrando anche quando ciò realmente non accade, fenomeno che alcuni ricercatori definiscono phantom phone, smartphone fantasma.
La nostra relazione con le applicazioni contenute nello smartphone è fondata sulla dopamina e sui meccanismi di ricompensa variabile (cd. circuiti di ricompensa dopaminergici), oltre al bisogno di sentirci in relazione con gli altri (quest’ultima cosa si basa su: Hypernatural Monitoring: A Social Rehearsal Account of Smartphone Addiction, di Samuel Veissiere e Moriah Stendel, della McGill University di Montreal, mentre per tutte le altre consiglio il classico di Nicholas Carr, Internet ci rende stupidi?).
La relazione ha un fondamento nella nostra biologia e fisiologia, e un articolo di legge non è uno strumento sufficiente per rispondere a stimoli di questo genere. Ecco, a fronte di un simile scenario immaginare un diritto alla disconnessione per i lavoratori è ridicolo, nel senso di un appiglio normativo estremamente fragile, almeno finché lo smartphone rimarrà con noi per molte ore al giorno.
Il capitalismo fatto persona avrà gioco facile a prediligere il remote working perché la relazione con la smartphone, e dunque anche con il lavoro, si basa su fattori biologici più incisivi di un manager occhiuto, che sbircia dalla scrivania affianco.
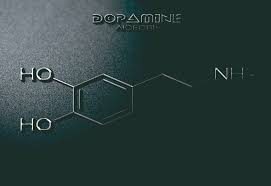
Abbiamo sentito parlare spesso di spillover in questo periodo pandemico, parola che indica il salto, nel caso del virus il salto di specie dal pipistrello all’essere umano, ma che qui indica l’invasione e la conquista da parte del tempo lavorativo del tempo che prima era dedicato alle faccende private. Un tracimare incontrollato e generalizzato, lavoro e riposo, lavoro e consumo (cos’altro è scorrere un social network se non consumare e lavorare gratis allo stesso tempo?), lavoro e relazioni, lavoro e acquisti; tutto ibridato da un oggetto e dalle applicazione in esso contenute.
Dovremmo cominciare ad ammettere che il tradizionale frazionamento del tempo nel corso di una giornata (lavoro-svago-riposo) è svanito; ormai siamo immersi in un tempo misto, friabile, in cui tutto si confonde, e non c’è più davvero la possibilità di isolare un momento delle 24 ore dedicato solo al lavoro, o solo alle nostre faccende private. Chi di voi se arriva una mail cd. urgente (il concetto di urgente nel lavoro meriterebbe un ampio discorso a parte), dicevo, chi, se arriva una mail urgente fuori orario lavorativo, riesce a non rispondere, a non guardarla nemmeno e comunque se non risponde riesce a evitare la sopraffazione del senso di colpa? Si accettano scommesse.
Che il lavoro da remoto stia scardinando alcune certezze lo chiarisce anche un articolo del Wall Street Journal, non un quotidiano qualsiasi, che lo scorso 31 luglio titolava così: «Is a Four-Day Week the Future of Work? Una settimana di quattro giorni è il futuro del lavoro?»
Il pezzo del Journal, che individua comunque aspetti problematici, porta l’esempio – con toni positivi – di Kickstarter: l’azienda sta sperimentando un progetto pilota in cui i dipendenti lavorano quattro giorni la settimana, a parità di retribuzione. Siccome la produttività, durante la pandemia e con il lavoro da remoto, non è mai diminuita, serve un modo di lavorare differente. Patrick Tomas, autore del pezzo, scrive: «Il Covid-19 sta mettendo in discussione le opinioni di vecchia data sulla struttura e la natura del lavoro, inclusa, per alcuni, la tradizione della settimana di cinque giorni e 40 ore. Il lavoro a distanza ha liberato i dipendenti da alcuni vincoli, ma ha anche provocato burnout (…) molti chiedono un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata quando torneranno in ufficio nel 2021».
Insomma lo spillover è ormai un dato di fatto e la soluzione potrebbe essere quella di lavorare meno, non per lavorare tutti, come recitava un vecchio slogan, ma per sopravvivere al burnout da smart working. L’articolo del Journal ammette che ci sono molti problemi organizzativi da risolvere, ma la strada da percorrere potrebbe essere questa.
Il fatto che la catena di montaggio dei cd. lavoratori della conoscenza stia nella tasca dei pantaloni o sotto il cuscino è un dato di fatto; che poi si possa lavorare 4 o 5 giorni alla settimana è un incognita. Rimane tuttavia che le diverse applicazioni dello smart working dovrebbero indurre una riflessione molto profonda sui nuovi tempi e i modi del lavoro, e sugli effetti che questi cambiamenti producono sul nostro modo di vivere, sulle città e sui territori (ne ho scritto in Lavorare (da casa) stanca).

Nel nostro paese lo smart working interessa 1/3 della forza lavoro, una percentuale rilevante, eppure non si scorge all’orizzonte una riflessione approfondita e necessaria su un tema tanto importante.





