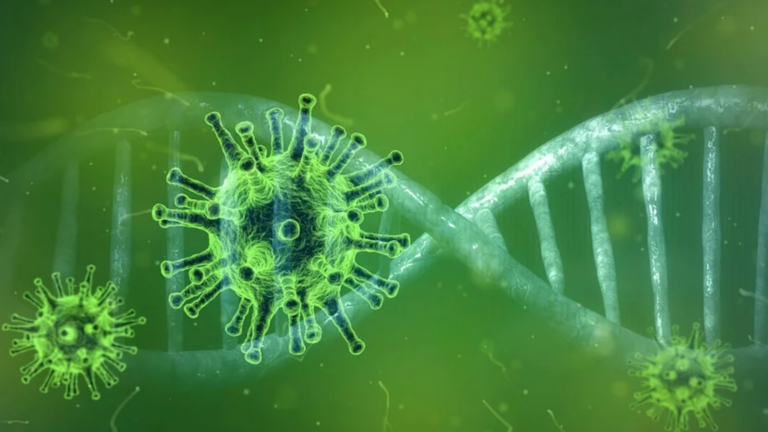Diciassette anni fa, quando il virus della SARS fece la sua comparsa, i social network erano già stati inventati, ma noi tutti o li ignoravamo , o li consideravamo un gioco.
I social network non connettevano miliardi di persone e non si erano trasformati nel sistema nervoso digitale del pianeta.
Non disponevamo, in buona sostanza, di un luogo in cui affogare o nutrire – a tempo – la nostra preoccupazione per un virus ignoto. In questi 17 anni abbiamo sconfitto la SARS (o forse si è sconfitta da sola) e abbiamo cambiato il modo di relazionarci tra umani, sia come individui che nelle formazioni sociali.

L’OMS, poco dopo che la notizia dell’epidemia di un nuovo virus sconosciuta è diventata di rilievo globale, ha fatto riferimento a una infodemia. Un’epidemia di informazioni non verificate, senza nessuna copertura scientifica. Succede e succedeva anche in passato. Molti, in queste settimane, hanno riletto Alessandro Manzoni, ma varrebbe la pena rileggere quel romanzo potente e allucinato che è Cecità, di Josè Saramago, poi il meraviglioso Diceria dell’untore di Gesualdo Bufalino.
Proviamo a mettere in fila alcune prime considerazioni sulle dinamiche che ci agitano in questa circostanza all’interno dello spazio digitale.
L’essere umano si spiega le cose e prende decisioni (la spiegazione è una decisione tra una ragione e un’altra) in due modi, due veri sistemi di pensiero.
Il Primo Sistema: «opera in fretta e automaticamente, con poco o nessuno sforzo e nessun senso di controllo volontario». Il Secondo Sistema: «indirizza l’attenzione verso le attività mentali impegnative che richiedono focalizzazione, come i calcoli complessi. Le operazioni del sistema 2 sono molto spesso associate all’esperienza soggettiva dell’azione, della scelta e della concentrazione», come spiega, in apertura di Pensieri lenti e veloci, Daniel Kahneman.
Negli ultimi 16 anni (ipotizziamo come data periodizzante la creazione di Facebook nel 2004) abbiamo fatto un grande uso del Primo Sistema, e ci quindi siamo sempre meno abituati a scegliere spiegazioni complesse, quelle del Secondo Sistema.
Se già prima eravamo propensi a utilizzare ricette precotte e comodi nemici, adesso lo siamo di più: cerchiamo ipotesi di complotto, rapporti di causa ed effetto semplificanti, banalizzanti. Oppure ci accontentiamo proprio di non capire, e inventare una qualche storia che stia un po’ in piedi.
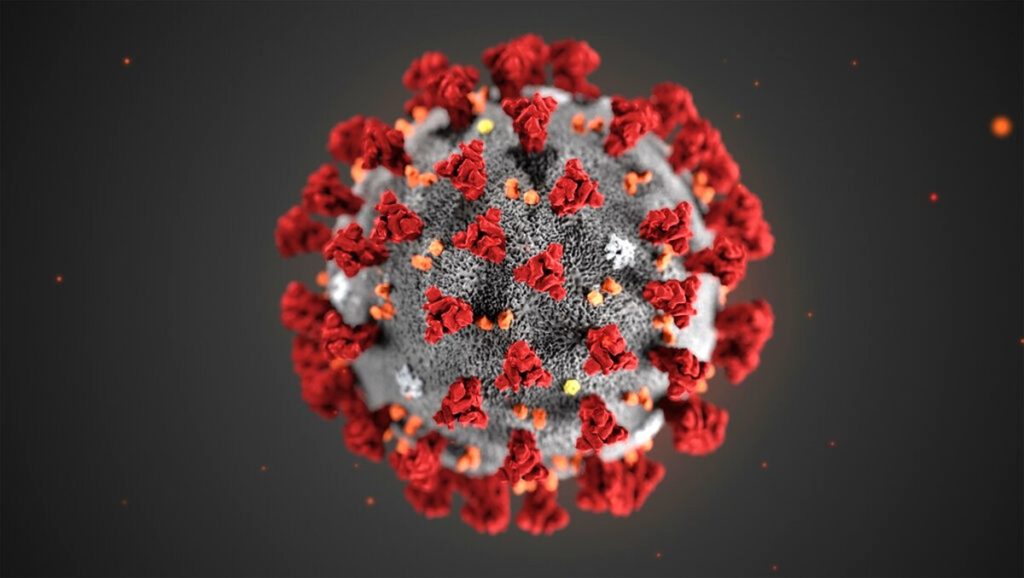
Parlo degli ultimi 16 anni, perché nel pianeta una parte importante e crescente della popolazione si nutre di informazione semplificata, spesso banalizzante, fatta di immagini, di Meme, di video, di poche righe di contenuto. Non necessariamente falsa informazione, ma informazione di assoluta superficialità, prodotta da chiunque, che ha una prevalenza visuale; un’informazione che mira spesso all’intrattenimento (parlo di informazione e non di giornalismo, volutamente).
Facebook e Instagram non prevedono la categoria dell’approfondimento. Invece l’epidemia ha proprio bisogno di approfondimento per essere compresa: dovremmo sforzarci di capire che le variabili in gioco sono molteplici, e alcune controintuitive.
La vicenda di Covid19 richiederebbe uno sforzo che vada oltre l’individuazione dell’untore anche adesso, anche al tempo della post-modernità. Il virus e la sua epidemia pretendono, insomma, un livello di complessità per il quale non bastano, perdonate la meta-semplificazione, i pochi caratteri di Twitter o una storia su Instagram.
Miliardi di persone cercano invece proprio l’untore e una spiegazione semplice, cercano un colpevole e condividono questa loro personale indagine sui social network, attribuendole un connotato emotivo prepotente. Un approccio in cui, ecco un elemento di novità, la velocità radicalizza sia il processo di semplificazione che l’innalzamento dei livelli di emotività.
Che il social network sia il sistema nervoso digitale del pianeta non è solo una metafora, rappresenta un modo per sottolineare come funzionano i social network stessi. La prevalenza dell’elemento emotivo è un fatto, ed alla base dei meccanismi di interazione. Diventa un fatto enorme quando l’essere umano si trova davanti alla prospettiva scioccante di un’epidemia, una pandemia o una quarantena. Situazioni sulle quali avevamo steso una delle tante, potenti, amnesie che caratterizzano il nostro stile di vita.
Anima vagula blandula, hospes comesque corporis, ci muoviamo come l’Adriano di Marguerite Yourcenar ma senza la stessa eleganza e consapevolezza; vagoliamo in cerca di senso, e di qualcosa che ci faccia capire cosa accade, mentre combattiamo con una certa idea del nostro corpo e con le preoccupazioni che ne derivano.
In questa fase stiamo andando a sbattere come mosche contro un vetro: ostaggi di brandelli di conversazione: il virus è simile all’influenza ma non è l’influenza; produce una patologia banale ma pericolosa; moriranno tante persone, per lo più anziani; abbiamo tanti casi perché ne misuriamo tanti. Un catalogo semplice di contraddizioni che si manifestano nella vita e in ogni spiegazione di fenomeno complesso, come quello dell’epidemia di un virus al tempo della globalizzazione.
Ed ecco perché – almeno così mi sembra – non si sia ancora manifestata una narrazione tossica che spieghi, alla pancia e al cuore, con immagini semplificanti, prima ancora che con parole, questo gigantesco intoppo nella nostra vita.
Una narrazione tossica che comunque arriverà. Bisogna solo aspettare, attendere che si vada solidificando questo stato di sospensione in cui una parte di noi è immersa, e che da questa sospensione possano generarsi favole, invenzioni, mitologie del presente, una nuova cartografia della diffusione del virus.
La storia di Covid19 è una storia che tiene insieme troppe varianti, ed è ancora presto per individuare un nemico preciso. Una delle caratteristiche tipiche della conversazione digitale – la polarizzazione – non riesce a prendere corpo, almeno fin qui.
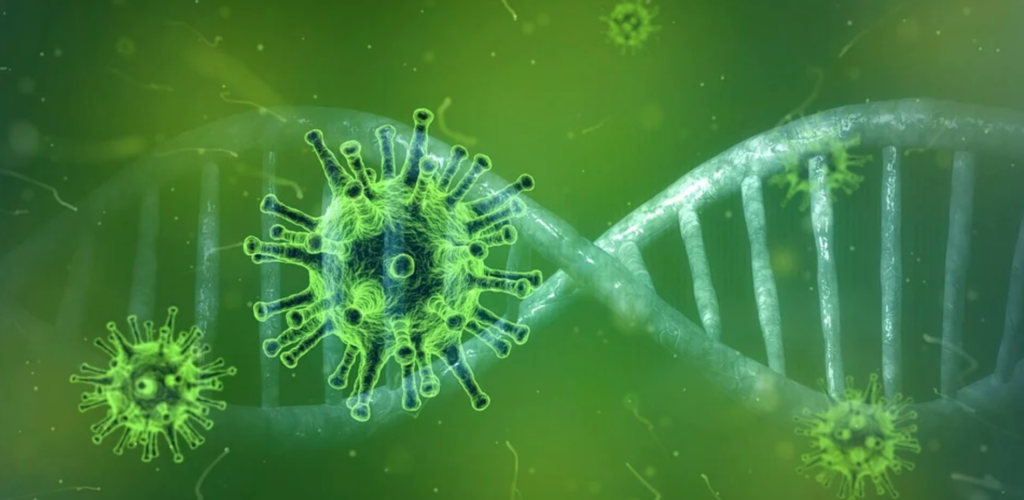
In Italia per dirne una la semplificazione sui migranti untori è andata in fretta a sbattere contro Codogno, la Lombardia e tutto il nord. In alternativa dentro Whatsapp circolano video con spiegazioni ridicole e affascinanti dell’epidemia, incentrate su un complotto improbabile di cinesi, WHO, governo britannico, Bill e Melinda Gates. Accanto a questa roba, una specie di manualetto del perfetto cospiratore, compaiono un po’ di Meme con la loro arma principale: l’ironia.
Si tratta soltanto dei primi Meme gettati in pasto al pubblico in questa circostanza. Dobbiamo attendere che venga superata la fase dello choc, del terrore, dell’incredulità, perché possano farsi strada quei diversi livelli di ironia sovrapposti che servono alla costruzione di un Meme, il quale nasconda in bella vista una posizione politica. C’è bisogno di molto più materiale, di più tempo, per arrivare a smontare e rimontare il senso dell’epidemia, e per colpire qualcuno: per trollare chi sta gestendo l’emergenza. Per entrare dentro le contraddizioni dell’epidemia e farne un gioco molto serio.
Di sicuro la posizione di chi fino ad oggi ha voluto innalzare muri, difendere confini, di chi chiede qualunque tipo di chiusura, che sfrutta la polarizzazione esaltata dagli algoritmi, rappresenta una posizione perdente sul piano logico prima, ed emotivo poi. Una posizione che si sostanzia in una sconfitta sul piano politico, ed è – infine – una cretinata su quello del buon senso.
L’aereo della nostra ex compagnia di bandiera, bloccato in un isola che è parte del continente africano, costituisce la più grande nemesi del salvinismo. Quell’aereo è il contrappasso per la Diciotti, per la Gregoretti, per i porti chiusi e per tutte le scemenze di quell’epoca.
Adesso tocca a noi essere fermati non in porto ma in aeroporto. I passeggerei di quell’aereo sono considerati indesiderati. Primi gli italiani a essere rimpatriati. Con la certezza che nell’immediato futuro forse lo diventeremo ancora di più, indesiderati, infetti addirittura.
Forse qualcuno verrà a chiudere i nostri confini, finché non smetteremo di essere contagiosi. Chiuderanno i nostri confini con noi stessi dentro; chiusi a chiave da fuori, a doppia mandata: padroni a casa nostra. E chi ancora, in queste ore, oppone la politica razzista che identifica uno Stato con un monolocale senza né porte né finestre, si sta finalmente scoprendo afono.
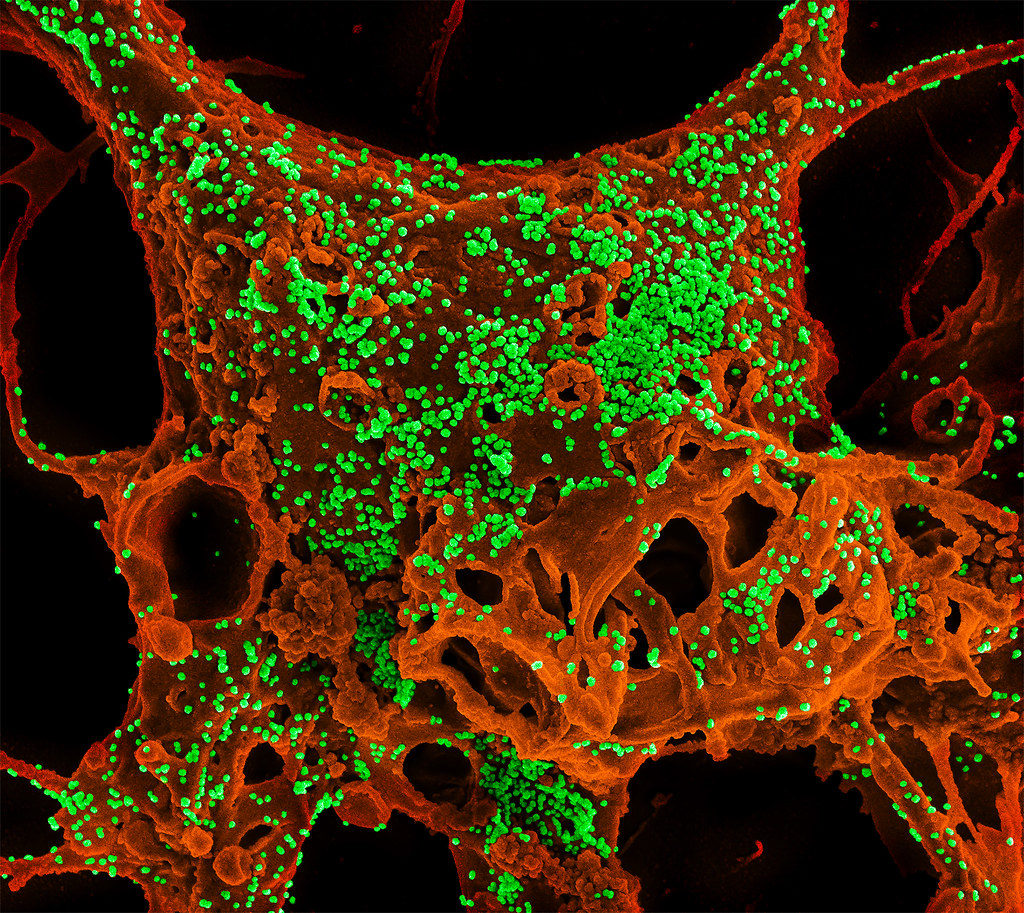
Un altro elemento tipico della conversazione digitale è quell’impermanenza che sta alla base della dialettica nei social network: ciò che oggi ci turba domani sarà presto dimenticato. Le nostre timeline hanno bisogno di rinnovarsi a ogni apertura di applicazione, e anche il post con maggiori interazioni scade in fretta. L’andamento degli stati emotivi di una nazione, del pianeta verrebbe da dire, soggiace a una dittatura dell’eterno presente.
Eppure stavolta non è così. Ecco un altro cortocircuito.
Abbiamo a che fare con una condizione che sposta l’orizzonte nel tempo in avanti, arricchendolo di una dose cospicua di elementi ignoti. L’epidemia presuppone un futuro anteriore colmo di incognite, una distanza temporale alla quale non siamo più abituati. Non siamo abituati a discorrere di dopodomani nei social network, perché il social network abilita soltanto l’eterno presente algoritmico. La storia di Instagram si esaurisce in sole 24 ore; siamo costretti a recuperare una temporalità che non maneggiamo più, se tentiamo di esprimere qualcosa che non sia una facile irritazione per un po’ di scaffali vuoti, in un supermercato di provincia.
Ha ragione Antonio Scurati quando afferma che in quest’epoca abbiamo un conto aperto con la morte, nel senso che non esiste un «equilibrato, “sano”, adulto rapporto con la morte». Ha meno ragione quando afferma che «nell’era d’Internet, non sappiamo vivere senza un’apocalisse all’orizzonte». Qui manca proprio l’orizzonte, non l’apocalisse. Manca l’orizzonte temporale. E basta osservarlo, l’orizzonte politico, divorato dalla cronofagia algoritmica, per scorgere la nostra quotidianità inghiottita insieme a ogni cosa. Divorata dal trending topic, divorata dalle funzioni che richiedono nuovi post a ogni scroll (scusate l’orrore fonetico), e quindi nuovi temi nell’agenda, nuove emergenze, nuovi sbarchi.
Nell’analisi dei comportamenti, e della psicologia collettiva, e della psicosi collettiva, non possiamo prescindere dalla comprensione delle funzioni che abilitano o disabilitano gli algoritmi. Rappresentano questi ultimi un elemento essenziale della nostra quotidianità, sono protagonisti dell’attribuzione di senso a fenomeni semplici e iper complessi per miliardi di persone. Dimenticare quanto conti l’oggetto-smartphone e il suo multiforme contenuto, nella definizione di come ci rapportiamo a tutta questa vicenda, costituisce un errore interpretativo importante. La nostra ansia si ciba di quello che scorre lì dentro, alternato a uno sguardo alla televisione. Il metronomo della preoccupazione batte oggi un tempo inedito. Mai ci saremmo aspettati di trovarci in una situazione simile, molti lo hanno detto, mentre molti altri cercano risposte in quell’oggetto che stavolta, però, offre scarne, esitanti, risposte.
Gli algoritmi, giova ricordarlo, propongono un tempo proprio, una cronologia indipendente dei fatti e dei contenuti che si lega ad altri innumerevoli fattori.
In questo senso l’epidemia registra una contraddizione temporale importante: da un lato la gestione dell’emergenza, hic et nunc; dall’altro lo sguardo al futuro per capire cosa accadrà domani.
Come dicono i tecnici per affrontare una situazione come questa servono prevenzione (blocchi e quarantene) e preparedness (diagnosi precoce e ricerca dei contatti), azioni che richiedono tempo, prospettiva, orizzonte, appunto.
Per il vaccino ci vogliono almeno 18 mesi.
Per la fine della quarantena ci vogliono settimane.
Per la fine dell’epidemia? Non si sa.
Per la fine del blocco dei comuni colpiti? Non si sa.
Abbiamo a che fare con il futuro, e ci siamo dimenticati come si fa.