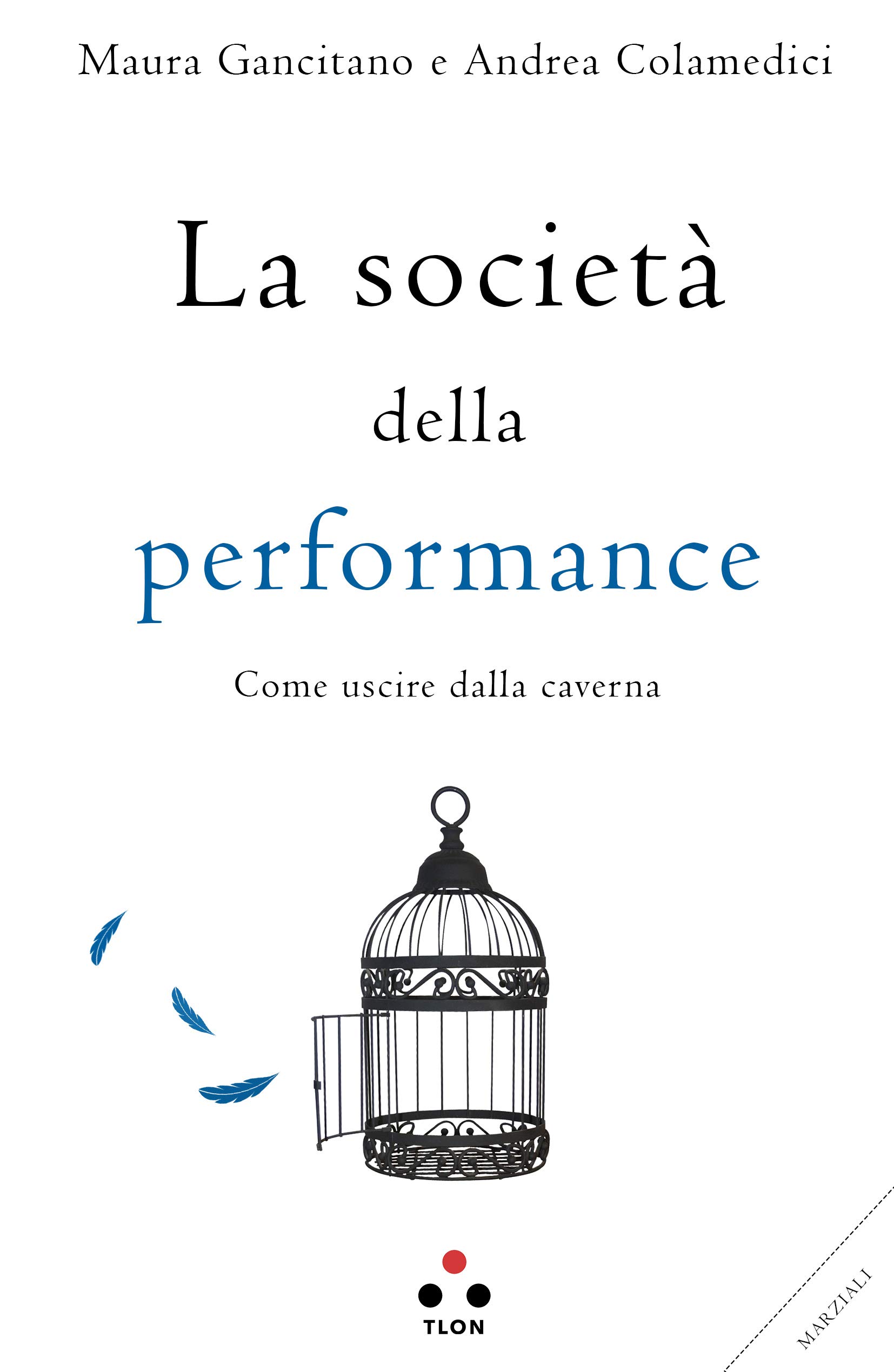Siamo immersi nella società della performance e non ce ne rendiamo conto. L’esempio dell’hashtag #10yearschallenge e della pratica che ha investito centinaia di milioni di persone impegnate a fotografarsi e a pubblicare una foto di come apparivano 10 anni prima, ne è la prova. La performance è l’accoppiata di queste due foto che asseconda un’onda insensata di comportamenti e che, come ogni performance, viene misurata e giudicata, quindi apprezzata e utilizzata per secondi e terzi fini.
La società della performance è un saggio (Tlon edizioni, p.200, 13,60€) scritto da Maura Gancitano e Andrea Colamedici che descrive il meccanismo di funzionamento della perversione collettiva cui tutti, consapevolmente o meno, ci sottoponiamo ogni giorno. Perversione in senso letterale, nel senso quindi di un “allontanamento delle norme morali e sociali condivise” fino quando non è esplosa in tutta la sua potenza la rivoluzione digitale.

La società della performance è l’evoluzione naturale della società dello spettacolo di Guy Debord: «una società – scrivono Gancitano e Colamedici – che divora tutto, rende tutto commercializzabile» in cui «non è più l’avatar a dover somigliare alla persona, ma la persona a dover essere all’altezza del proprio avatar».Stiamo attraversando un momento in cui la bibliografia di chi prova a fornire chiavi interpretative del presente digitale si estende a dismisura, e in tanti provano (proviamo, anche chi scrive ha tentato) a orientare i lettori, a spiegare come resistere, come disintossicarsi. Con merito e con impegno molti autori partono spesso dall’analisi della struttura del presente digitale, dalla natura e dai meccanismi di funzionamento degli algoritmi.
Gancitano e Colamedici, invece, prima propongono definizioni che scarnificano il presente (vi basti homo homini opus), vie di fuga che non prevedono l’esilio o l’autoesilio, e infine tentano una strada differente rispetto a tanti altri testi simili: il lato del prisma, attraverso il quale propongono una lettura dell’attualità complessa che abitiamo, ha a che fare con la nostra mente e con la nostra anima. Gli autori sono filosofi e non possono che partire da qui: «ciò che rafforza la società della performance – scrivono – non è il progresso tecnologico, ma è la meccanica della nostra mente, il modo di intendere e valutare l’esistenza e la socialità. (…) Nessuno oggi può sfuggire davvero al paradigma culturale della performance». E aggiungono che questo modello si realizza «ogni volta che ci costringiamo a inventarci un progetto o produrre un contenuto per dimostrare di essere produttivi, cioè per dimostrare di esistere».
Hanno ragione i due autori quando affermano che il paradigma culturale digitale sta plasmando la meccanica della nostra mente: per la maggiore parte delle persone e per come queste persone vi si immergono, l’accesso alle piattaforme digitali non è un gioco, crea dipendenza e modifica alla radice il modo di sentire e di pensare. Tuttavia Gancitano e Colamedici partono dal mito della caverna di Platone e ne escono senza timori, senza la paura di non essere ascoltati, creduti. Provano a indicare con le parole di Hölderlin una via d’uscita: “là dove c’è il pericolo, cresce ciò che salva“.
Tre le ragioni, tra le tante, per cui questo libro va letto, cui annetto divagazioni sentimentali e personali.
La prima è che La società della performance è un libro di libri e non poteva essere altrimenti visto che Gancitano e Colamedici hanno fondato una casa editrice intitolata a un magistrale racconto di Borges, Tlön. Chi vi scrive ama sommamente i libri di libri e ne subisce il fascino, come una debolezza, quasi sentendosi la vittima di una seduzione che genera effetti a catena impensati, imprevedibili. Il testo è una miniera di citazioni e di rimandi, un vero ipertesto filosofico, un modo di inchiodare la lettura della società della performance a riflessioni che affondano le radici nella storia del pensiero.
La seconda altrettanto sentimentale perché identifica la via di fuga nella flânerie, nell’imprevedibilità della flânerie, che nell’universo digitale significa anche raccontare balle agli algoritmi, e che gli autori traducono con gli esperimenti di Harold Garfinkel: «cosa succede quando rompo la routine quotidiana? (…) Con i suoi esercizi di rottura Garfinkel intendeva mettere in discussione questo senso di ovvietà spingendo i propri allievi, ad esempio, a considerare non assodato un elemento comunemente considerato come ovvio. (…) Prova a chiedere a qualcuno: “che ore sono?”. Alla sua risposta (mettiamo ad esempio “Mezzogiorno”), chiedi: “in che senso?”».
L’ennalogo del Manuale di disobbedienza digitale è colmo di elementi di rottura e nonsense di questo tipo, ecco un’altra ragione sentimentale di pura consonanza e sintonia.
La terza ragione affonda le radici nella mia storia personale, in due episodi correlati tra loro. Una mia amatissima zia, la zia Nanne, mi invitava spesso ad ascoltare con cura (e con una certa dose di ispirazione, direi oggi) i discorsi di quelli che lei definiva basagliani. Si riferiva ai primi simpatici picchiatelli, finalmente liberi grazie a Franco Basaglia di varcare le mura dei manicomi, e che allora cominciavano a passeggiare e popolare le strade della città. Ascoltare i discorsi dei matti, aveva ragione mia zia, è affascinante: spesso sono discorsi incomprensibili, mormorati o urlati dal bordo di un marciapiede all’indirizzo di un albero o di un passante, intrisi di dolore e colmi di sentimenti di cui non si scorge l’origine, in cui affiorano bagliori di remote esistenze, si materializzano piani e relazioni impossibili, interlocutori immaginari e reali. Meritano un ascolto attento, non foss’altro che per l’assoluta irripetibilità da parte di un qualsiasi uomo che può gestire solo la sua banale e ordinaria follia. Anche soltanto per il fatto di essere difficile da replicare, li dobbiamo chiamare discorsi, restituire loro una dignità che li colmi d’affetto e insensata comprensione.
E sempre per restare in famiglia, ricordo che anni fa proponevo a mia sorella piccola il gioco di costruire frasi senza senso, “oggi ho mangiato una ringhiera di ghiaccio mentre ascoltavo il sole precipitare nel cappuccino dello zio Enzo addormentato in un cassetto di latte“, e ricordo che dopo poche frasi un po’ originali, si strutturava subito un canone al quale si tornava sempre, sempre a quel modello si finiva; quel palinsesto si imponeva alla nostra pigra facoltà creatrice, o meglio quel canone trovava un ostacolo naturale nel dire razionalmente l’irrazionale. Risulta pressoché impossibile, anche con uno sforzo titanico, parlare senza costrutto. Nessuno può davvero imitare, scrivere o dire le parole di un matto, ugualmente sforzarsi di farlo è un esercizio che vi porrà di fronte a sorprese innumerevoli.
Perdersi volendo perdersi appartiene allo stesso livello di difficoltà e coincide con un genere di desideri complicati da soddisfare.
Tuttavia hanno ragione Gancitano e Colamedici: perdersi è una soluzione sebbene sia una soluzione molto difficile se presa alla lettera, la flânerie è terapeutica e va ugualmente considerata come un farmaco dagli enormi effetti collaterali, eppure non abbiamo molte altre possibilità se non provare. «È l’azione e meditazione del futuro la flânerie, fatta con il corpo e tutti e sei i sensi, immersa in un Altrove che è anche Qui. Non finirà il mondo se smettiamo di correre dietro alla lepre meccanica del cinodromo che abitiamo. (…) Parafrasando Borges, un essere umano si propone di disegnare la città solo attraverso i propri passi. Nel corso degli anni popola uno spazio con immagini di giardini, di strade, di bar, di luci, di fiumi, di palazzi, di vicoli, di astri, di biciclette e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto».