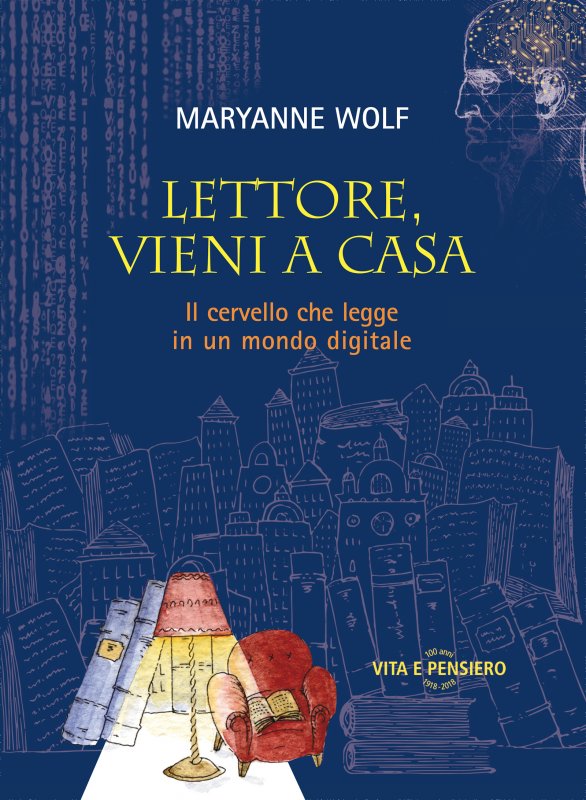La notizia: 400 dipendenti di Alphabet, la casa madre di Google, si è iscritta un sindacato. Anzi hanno creato una sezione aziendale del sindacato dei lavoratori della comunicazione d’America. Più che una piattaforma di rivendicazione, sul proprio sito, il sindacato espone una piattaforma politica che va oltre il perimetro di Google: «il nostro sindacato si impegna a proteggere i lavoratori di Alphabet, la società globale e il mondo. Promuoviamo la solidarietà, la democrazia e la giustizia sociale ed economica». Più in dettaglio gli aderenti descrivono alcuni elementi sui quali avviare una contrattazione con l’azienda e garantire che le condizioni di lavoro siano inclusive ed eque; che gli autori di molestie, abusi, discriminazioni e ritorsioni siano ritenuti responsabili; che i lavoratori possano rifiutarsi di lavorare su progetti che non sono in linea con i nostri valori; che tutti i lavoratori, indipendentemente dalla condizione occupazionale, possano godere degli stessi vantaggi (vasto programma, si sarebbe detto un tempo).

La vera novità è l’esistenza stessa del sindacato. E quindi il fatto che, in tutta segretezza, in una delle più importanti aziende del mondo, un gruppo di dipendenti abbia sentito il bisogno di associarsi per confrontarsi. Insomma si apre una breccia nella Silicon Valley, che fin qui ha sempre manifestato ostilità verso qualunque soggetto che volesse difendere gli interessi dei lavoratori. Tra i temi più importanti c’è quello di un approccio etico alla tecnologia, del razzismo e delle molestie sessuali sul luogo di lavoro. E il sindacato potrebbe fare molto in un universo che possiamo definire, senza timore di smentita, maschilista (qui su Disobbedienze ho scritto Femminile tecnologico).
Più in generale, bisognerà vedere se questo tentativo avrà un futuro. Come ha detto al New York Times Veena Dubal, professore di diritto all’Università della California, si tratta di «un “potente esperimento” che ha portato la sindacalizzazione in una grande azienda tecnologica. Se cresce – e Google farà tutto il possibile per evitarlo – potrebbe avere enormi impatti non solo per i lavoratori ma per questioni più ampie».
Siamo certi che la professoressa Dubal abbia ragione fino in fondo?
Questa buona notizia lascia un retrogusto amarognolo. Il sapore del cozzare implacabile di un certo idealismo sul vetro spesso del pragmatismo, del realismo.
Se da un lato è vero, come scrivono gli aderenti alla Alphabet Workers Union, che il loro lavoro ha un impatto sugli altri dipendenti di Alphabet, sulle nostre comunità e sul mondo, siamo davvero certi che possa davvero funzionare un sindacato dentro Google? Provo a spiegarmi: è realmente utile sia a Google che al mondo?
Lo stipendio medio, ripeto medio, di un dipendente di Alphabet è poco più di 250.000 dollari, duecentocinquantamila dollari. Di rivendicazioni salariali, quindi, il sindacato non si occuperà; e più in generale non sembra che si occuperà di contrattazione.
Mentre i dipendenti di Google sono dei privilegiati, i moderatori di contenuti di YouTube – che è di proprietà di Alphabet – no, non lo sono. Il sindacato sarà un buon sindacato se servirà a migliorare le condizioni di lavoro di questi ultimi. Per il resto chi lavora dentro Alphabet, come in altre grandi techno-corporation, ha una quantità di benefit impressionante. Tutto ruota intorno a condizioni materiali che spingono a un lavoro matto e disperatissimo, ma che i dipendenti sono portati a considerare come una specie di hobby, come un servizio alla comunità, come un impiego con fini di ricerca, umanitari, di sviluppo della conoscenza e non, com’è naturale che sia, per il profitto degli azionisti.
I numeri contano: 400 dipendenti sono una notizia, non una rappresentanza sindacale. Alphabet ha oltre 120.000 dipendenti e altrettanti fornitori esterni.
Da quando Google è nata in un dormitorio dell’Università di Stanford, e da quando Sergey Brin e Larry Page l’hanno quotata a Wall Street fino a oggi, poche cose sono cambiate nel cuore del business aziendale. Di sicuro sono mutate le dimensioni.

Molti giovani sindacalisti chiedono oggi proprio di riandare alle origini della società: «voglio che Google torni al suo motto, “non essere cattivo”», scrive Ashley Smith, ingegnere del software. Tim Wilde, un altro ingegnere, dice: «mi piacerebbe vedere Alphabet tornare ai valori della lettera dei fondatori» (quest’ultimo è un testo fondativo, su cui si basa l’eccezionalità di Google e di molte altre aziende della Silicon Valley, e che predica la “non convenzionalità” dell’azienda).
Per la verità le origini di Google non sono granché diverse dalla maturità di Google. All’epoca mancava un modello di business che poi è arrivato. Oggi Alphabet è una società quotata a Wall Street, una delle più grandi al mondo, la terza per valore complessivo dopo Apple e Amazon; e i suoi amministratori cercano di fare il mestiere per il quale sono pagati: guadagnare denari. Anche con gli appalti del Pentagono, che il sindacato contesta senza parlarne esplicitamente (tra l’altro invito a leggere il racconto della genesi del motore di ricerca, e le sue cointeressenze con i militari, nella ricostruzione che ne fa Soshana Zuboff ne Il capitalismo della sorveglianza). Google ha prosperato su un racconto, una mitopoiesi, che nascondeva la sua appartenenza al capitalismo del ventunesimo secolo, e collocava se stessa all’interno di un perimetro di combattenti libertari che lottava per la modernizzazione del mondo intero. Per questo i sindacalisti chiedono un ritorno alle origini. Eppure nella lettera dei fondatori, l’anno della quotazione a Wall Street, Page e Brin dicevano due cose ben precise: «il nostro dovere è promuovere gli interessi dei nostri azionisti»; e poi illustravano «una struttura aziendale progettata per proteggere la capacità di Google di innovare e mantenere le sue caratteristiche più distintive». Un modello di governance che avrebbe ispirato tutto il capitalismo digitale.
Gli aderenti alla Alphabet Workers Union abitano e lavorano nel cuore del sistema di Alphabet, al centro di processi produttivi essenziali, tuttavia avranno una capacità d’azione limitata: potranno al massimo segnalare casi di discriminazione o poco più.
Gli NDA, i non disclosure agreement, gli accordi di non divulgazione, pesano più della rappresentanza sindacale. Chiunque viene assunto in Google deve firmare un NDA, perché la sua intelligenza è al servizio di un’intelligenza più grande, artificiale e segreta, l’algoritmo.

Il tema centrale a me pare proprio questo.
Si pensa di poter rappresentare Google come una fabbrica con le regole della vecchia fabbrica otto-novecentesca, e di attribuire ai lavoratori di Google gli stessi interessi, gli stessi itinerari rivendicativi, che avevano – e hanno – gli operai nelle fabbriche. Per non parlare della forza politica. Non è così. L’abbiamo detto i googler sono lavoratori privilegiati rispetto alla stragrande maggioranza dei lavoratori del pianeta. Sono parte di un’élite di lavoratori della conoscenza iper-preparati, coccolati, ricercati e molto ben pagati, come abbiamo visto.
Tra l’altro se guardiamo al sistema produttivo, nell’ottocento, nella Londra di Dickens e Marx, i lavoratori erano gli sfruttati, qui gli sfruttati – in maniera inedita, inconsapevole e senza una costrizione all’interno dei una fabbrica – sono gli utenti (il rimando è sempre alla Zuboff).
Google realizza la sua produzione e il suo enorme profitto grazie a un’intelligenza artificiale, certo realizzata con il concorso di molti uomini nel corso del tempo, che potrebbe – senza particolari problemi – prescindere dagli uomini per la sua operatività. L’apporto degli umani è decisivo ma non essenziale: non servono gli uomini per far funzionare Google e la sua linea di produzione. Non servono umani per accendere la fabbrica Google, per regolare la temperatura delle macchine, per seguire i pezzi che escono dalla linea alla fine del processo di lavorazione, non servono persone che sovrintendano alla consegna del prodotto. La catena di montaggio digitale di un algoritmo complesso come il Page Rank (l’algoritmo di Google) ha bisogno di interventi di manutenzione e correzione, ma se nessuno ci mettesse le mani per settimane, forse anche per mesi, il sistema potrebbe andare avanti lo stesso. Accoglierebbe ugualmente le domande nella stringa di ricerca, fornirebbe ugualmente risultati agli utenti, apprenderebbe dai loro interrogativi e dalle loro risposte, e da molti altri loro segnali; e di conseguenza continuerebbe a portare soldi nelle casse aziendali.
L’intelligenza artificiale auto-apprende. Per usare uno slogan, potremmo affermare che un algoritmo non si iscrive al sindacato.
Purtroppo tutta questa vicenda segna una pesante sconfitta per la politica. Il sindacato è chiamato a svolgere un ruolo vicario, di supplenza, laddove le istituzioni – e i partiti – non sono state in grado di porre un confine, quando era ancora possibile. Quello che chiedono oggi i sindacalisti di Google, e cioè «rendere Google responsabile nei confronti dei suoi lavoratori e della società in generale», dovevano pretenderlo i parlamenti.
Esistono le diseguaglianze nella Silicon Valley, si pensi ai moderatori di contenuti, giusto per fare un esempio. Dovrebbe essere la politica a chiedere conto delle storture che il tecno-utopismo ha creato nel corso degli anni.
Ancora oggi l’atteggiamento nei confronti della Silicon Valley, qui almeno, porta ad intervistare Elon Musk con il cappello in mano, trattandolo come un imprenditore visionario – cosa che è – ma senza chiedergli conto della pretesa di tenere aperta la sua fabbrica in California, a dispetto della pandemia, e prima ancora di aver strutturato protocolli di sicurezza. Oppure di evitare di chiedere conto a Jeff Bezos, editore del progressista Washington Post, del sale che la sua creatura, Amazon, sta spargendo sulle ceneri del piccolo commercio.
I giovani googler che esultano per il sindacato appena costituito, e pretendono un ritorno alle origini, sognano di tornare all’era mitologica in cui la gratuità, forgiata nella fornace di Burning Man, ha cominciato ad applicarsi a ogni cosa, alle notizie per esempio, rendendole una commodity, un bene senza valore.
La domanda rimane intatta: a cosa serve un sindacato dentro Google?